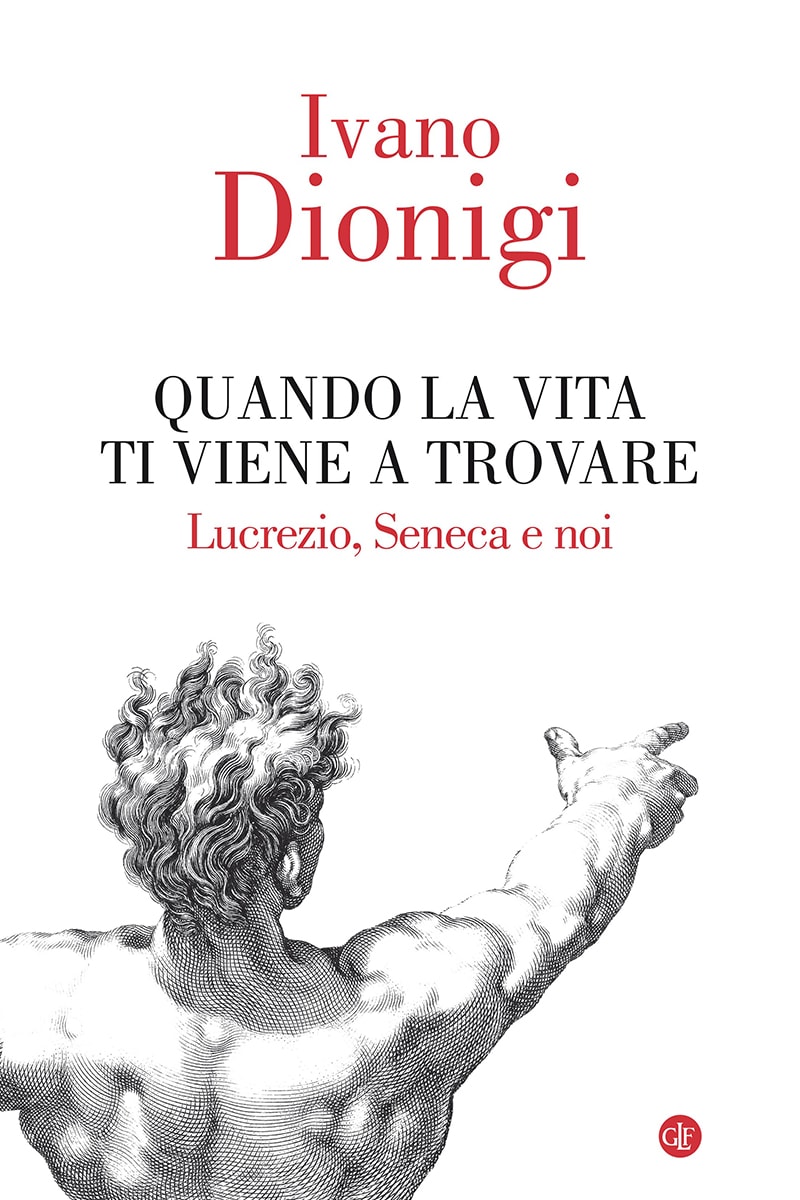Scultura romana di Cleopatra VII al Antikensammlung Museum, Berlino (Ph. by Sailko, CC by 3.0, via Wikimedia Commons)
Marino Niola, “La Repubblica”, 12 dicembre 2018
Senza Cleopatra il mondo non sarebbe lo stesso. La sua bellezza leggendaria, la sua intelligenza spiazzante e la sua cultura raffinata ne hanno fatto l’indiscussa primadonna sulla scena dell’antichità. La protagonista assoluta di quel periodo tempestoso che va dall’uccisione di Cesare alla nascita dell’impero augusteo.
Adesso, tutto quello che avreste voluto sapere sulla mitica regina e che non avete mai osato chiedere, lo trovate nel nuovissimo libro di Alberto Angela, Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità (Rai Libri e HarperCollins, pagine 446).
Un testo, dotato di immagini e cartine, che illumina il pubblico e il privato della donna più chiacchierata, amata e odiata di sempre.
Angela, con il talento del narratore e l’immediatezza comunicativa del divulgatore ricostruisce l’affaire Cleopatra seguendola come un reporter.
Minuto per minuto, ora per ora, domus per domus. La pedina con il suo passo felpato, mettendo sempre i fatti al centro della narrazione.
Sia gli eventi storicamente accertati, sia quelli ricostruiti attraverso indizi, congetture, intuizioni. Il risultato è un affresco storico avvincente e convincente. Pieno di azione e di emozione.
Come quando racconta la reazione della sovrana d’Egitto che, nella sua lussuosa villa al di là del Tevere, riceve la notizia dell’assassinio di Cesare. In quel momento in cui il futuro del suo Paese e dell’intero Mediterraneo è sospeso come sulla lama di una spada, il crollo del suo progetto politico si sovrappone alla fine del suo sogno d’amore e alla sua inquietudine di madre per la sorte del figlio Cesarione.
E mentre il popolo romano interrompe i festeggiamenti in onore della dea Anna Perenna si chiude in casa fra timori e tremori.
L’autore lancia i protagonisti della vicenda come dadi sul panno verde della storia.
Antonio, Bruto, Cassio, Ottaviano, Agrippina, Mecenate. Col trascorrere delle pagine «questi dadi, rotolando e piroettando, prima di fermarsi mostreranno una faccia vincente, poi una perdente, poi di nuovo una vincente e così via, in un crescendo di tensione in cui non si capirà mai chi stia per trionfare».
Da narratore accorto, Angela crea e ricrea, sequenza dopo sequenza, un clima di suspence, come in un giallo di cui è noto l’epilogo, ma sono molto meno chiare le trame e i retroscena che conducono il thriller verso la sua conclusione.
Insomma oltre l’aspide c’è di più. C’è perfino il sospetto che fosse un cobra. O addirittura che la donna abbia bevuto un cocktail letale, il che scagionerebbe il serpente.
Angela sottopone la vicenda a un trattamento cinematografico. Pieno di inquadrature inaspettate, di particolari dimenticati, di messe a fuoco rivelatrici.
Come quella dove Cleopatra, vestita da Afrodite sotto un baldacchino d’oro nella sua barca dai remi d’argento, seduce Antonio in un’atmosfera tra l’erotico e l’estatico.
In realtà dietro quella scintillante spirale di languore c’è il lucidissimo disegno della regina che cerca protezione per il suo regno, vuole tracciare dei confini entro cui essere amata, come le farà dire Shakespeare.
Bella e non solo, dunque. In questo senso l’autore ha il merito di aver fatto emergere, dietro la maschera della femme fatale, della «Cleopatràs lussuriosa» come la chiama Dante, la realtà di una donna ricca e colta, maestra dell’arte della persuasione e grande mediatrice tra Oriente e Occidente.
Un grande simbolo di quella globalizzazione prima della globalizzazione che fu l’ellenismo. In effetti il racconto di Alberto Angela fa uscire Cleopatra dal mito per farla entrare nella storia e infine la restituisce al mito. Ma con tutti gli onori.




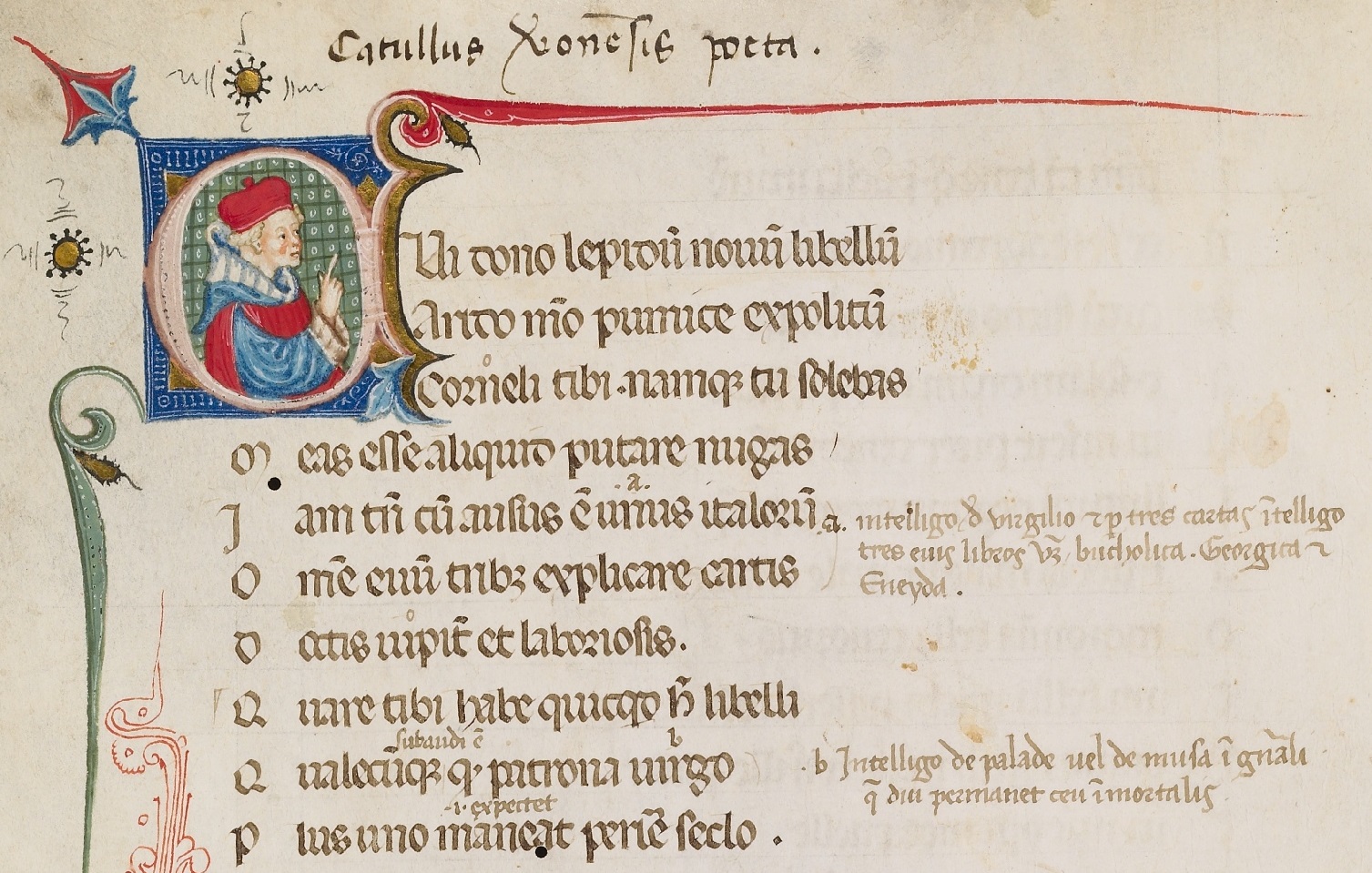
 Nunzio Bianchi, “il manifesto”, 2 dicembre 2018
Nunzio Bianchi, “il manifesto”, 2 dicembre 2018